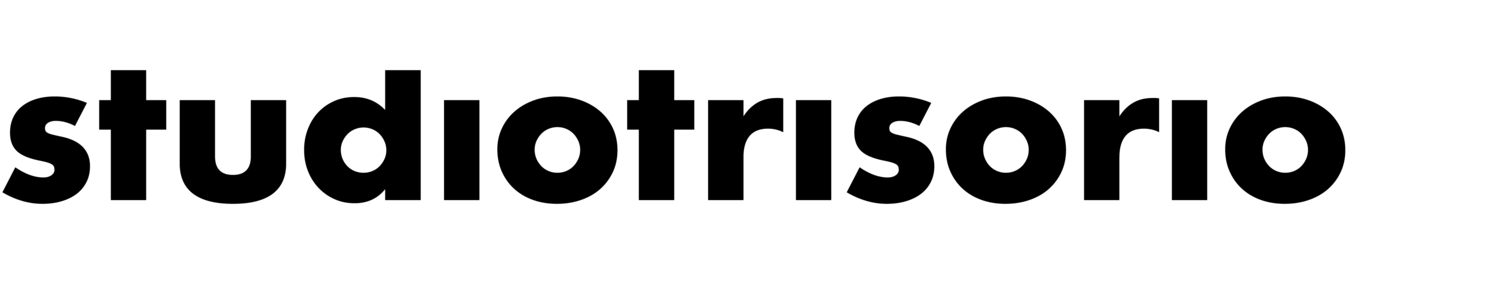Carroll oltre il quadro
la repubblica / 30 aprile 2022
L’artista americano scomparso nel 2019 realizzava opere come porte aperte su altri mondi
E ora il museo Madre di Napoli gli rende omaggio
Lawrence Carroll amava l’Italia, l’amava a tal punto da esserci venuto a vivere. Lui, nato in Australia nel 1954, emigrato giovanissimo in America con la famiglia, cresciuto tra Los Angeles e New York, amico degli artisti più importanti del secolo scorso, alla fine aveva voltato le spalle al palcoscenico che forse poteva dargli prima e meglio la fama che la sua arte merita. E aveva voluto ritirarsi proprio qui: una periferia artistica, ma il luogo perfetto per immergersi nella storia della pittura e nella luce mediterranea.
E oggi la luce calda del Mezzogiorno che inonda le sale del Madre crea uno spazio perfetto per la sua opera, esaltandone potenza e bellezza. In fondo Carroll e Napoli si assomigliano. I colori che emanano da tanti quadri – pennellate di bianco sporco, di diafana cera, di avorio, di giallo e ocra, di terre di Siena bruciata, di un tenue azzurro – sono gli stessi della città. Come quell’aria un po’ casuale, disordinata, scrostata, fragile: nulla è perfetto nella sua pittura perché tutto è vivo.
È la prima grande retrospettiva (a cura di Gianfranco Maraniello, in collaborazione con Lucy Jones Carroll, fino al 5 settembre) dedicata all’artista scomparso 3 anni fa: 80 opere, dal 1985 in poi, che includono anche una decina di scatti del tutto inediti. Passione tardiva, ma sapiente, quella della fotografia. «È incredibile che fosse così bravo pure con l’obiettivo» ha commentato all’inaugurazione un artista fotografo come Antonio Biasiucci. Sono piccole inquadrature di paesaggi o nature morte, fiori secchi – che tanto amava – bandiere flosce, palle di neve, foglie. Ma la visione è sempre sporca, graffiata, vista attraverso vetri opachi, segnati da incrinature: quei vetri sono il filtro che rendono personale lo sguardo, trasformano un panorama in un vissuto, restituiscono lo spazio interno – e interiore – da cui si guarda.
È il tema di tutta l’opera di Carroll. Il quadro non è una superficie da dipingere, è un corpo che porta i segni dell’esperienza, ne conserva le ferite, ne mostra le cicatrici: sono le cuciture che riuniscono la tela lacerata, ne tengono insieme i vari frammenti, e che vengono “guarite” dalla cera. Proprio così: «Pensavo – ha dichiarato – alla tela come un pelle, alla cera come un unguento, alle sue capacità curative».
Se il quadro è un corpo allora ha anche un volume, si protende nello spazio, può essere profondo anche venti, trenta centimetri, può lasciare che si aprano piccoli ripostigli al suo interno, dove riposano tele ripiegate, sassi, fiori, rami, lampadine accese o spente, scarpe, pagine di giornale su cui ha dipinto: tutti i lacerti di vita che il pittore ha raccolto sono inglobati nella pittura, che assorbe e trasforma ogni cosa.
Stampata sulle pareti del Madre una frase dell’artista recita: «Mi piaceva l’idea di un quadro come fosse un luogo. Un luogo in cui entrare, da occupare, dove scaricare qualcosa che stavi portando con te». Ed ecco Closet, (armadio, sgabuzzino) che ha una porta aperta proprio come un armadio e che offre allo sguardo del visitatore l’intimità della sua collezione: fiori, fotografie, cornici, una riproduzione dell’amato Morandi, buste, merletti, suppellettili. Un piccolo museo dei ricordi, un gabinetto dei depositi emotivi che ne custodisce uno particolarmente prezioso: un paio di scarpe di Rauschenberg. Carroll gliele aveva chieste e il maestro americano non aveva esitato a donargliele. Averle messe nell’opera è un riconoscimento e un omaggio. «In inglese – fa notare Maraniello – mettersi nei panni di qualcuno si dice get in the shoes of, mettersi nelle sue scarpe». E sicuramente l’esordiente Carroll ha qualche debito nei confronti di Rauschenberg, se riesce a creare arte persino con il ghiaccio: il Mambo di Bologna, in una mostra sempre curata da Maraniello, otto anni fa aveva esposto il gigantesco Freezing Painting, un enorme tela gialla che si scongela lentamente. Qui a Napoli ci sono due opere più piccole, una con degli scarponi, l’altra con delle foglie circondate dal ghiaccio. Introducono però lo stesso tema: il lento inesorabile respiro del tempo. Ma ciò che rende speciale, unico, il lavoro di Carroll è essere riuscito ad unire la prepotente fisicità di ogni sua opera – le tele grezze e spesse, le assi sdrucite, i vetri sporchi, i ritagli di stoffa – con la qualità, la luminosità della sua pittura. Così anche un piccolo cubo con il solo lato superiore azzurro – il cielo? – o una colonna di cassette di legno sfondate e sovrapposte, possono diventare una visione.
E pensare che tutto nasce da un’idea di auto-cancellatura: “Volevo dipingere i miei quadri del colore della tela, così da poter sempre cancellare me stesso e ricominciare da capo”. Ma quel bianco sporco, quell’incarnato pallido, quel caldo avorio sono tutto tranne che una cancellatura: sono al contrario strati di vita stesi con il pennello, pittura vibrante che illumina ogni cosa su cui si poggia. E rende questa mostra bellissima. Se potete, visitatela in un giorno di sole.
Gregorio Botta